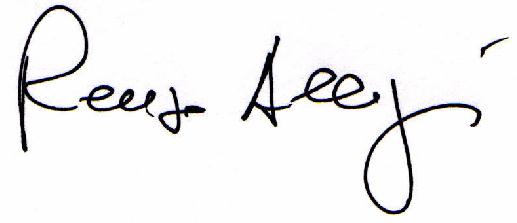Ricordi storici e inediti in questa lunga intervista con il più
grande interprete verdiano del Novecento, che l’11 dicembre scorso è
stato festeggiato al Teatro La Fenice di Venezia.

CARLO BERGONZI: UNA VITA NELLA MUSICA
di Renzo
Allegri - Foto di Nicola Allegri
Copyright
© 2007 editorialegliolmi.it
tonyassante.com
Acquista i dischi di Carlo Bergonzi online
Il tenore Carlo Bergonzi è stato festeggiato
sabato 11 dicembre al Teatro La Fenice di Venezia, con la consegna
del premio “Una vita nella musica - Artur Rubinstein”. Nato 86 anni
fa, a Vidalenzo di Polesine Parmense, un paesino a due chilometri da
Busseto, città natale di Giuseppe Verdi, Bergonzi è ritenuto il più
grande interprete delle opere verdiane.
<<Sono particolarmente felice di questo premio>>, dice il tenore.
<<A Venezia mi legano ricordi importanti. Nel 1957 interpretai
“Cavalleria Rusticana”, allestita in Piazza San Marco. In quell’occasione,
incontrai Angelo Roncalli, che era patriarca di Venezia e l’anno
successivo sarebbe diventato Papa con il nome di Giovanni XXIII.
Poi, interpretai il “Requiem” di Verdi a Palazzo Ducale con la
direzione di Herbert Von Karajan. Al Teatro La Fenice interpretai
due edizioni di “Aida”, e “Un ballo in maschera”. Per me, La Fenice
è il più bel teatro che ci sia al mondo, un vero gioiello
artistico>>.
Il premio, “Una vita nella musica”, è
prestigioso perché vanta una storia trentennale. E’ stato fondato da
Bruno Tosi, musicologo veneziano appassionato di lirica, conoscitore
di tutti i grandi interpreti e in particolare di Maria Callas, alla
quale ha dedicato libri e mostre, ed è diventato un premio di fama
internazionale. E’ stato attribuito ai più grandi protagonisti del
mondo musicale del nostro tempo. Da Artur Rubinstein, il primo, nel
1979, che ha dato il proprio nome al Premio stesso, seguito da
personaggi mitici quali Andrès Segovia, Karl Bohem, Carlo Maria
Giulini, Yehudi Menuhim, Mistislav Rostropovic, Gianandrea Gavazzeni,
Leonard Bernstein, Isaac Stern, Maurizio Pollini, Claudio Abbado,
Salvatore Accardo, Zubin Mehta, eccetera. Non poteva mancare Carlo
Bergonzi, che alla musica lirica ha dedicato letteralmente tutta la
sua lunga esistenza, avendo iniziato a cantare romanze verdiane da
ragazzino e continuato poi fino a ottant’anni. E ancora oggi,
quando, in casa sua, si mette al piano e canta, sfoggia una voce e
una intonazione perfette.
<<A nove anni, mio padre mi portò a vedere il
“Trovatore”, nel piccolo Teatro di Busseto>>, dice Bergonzi. <<Ne
rimasi sconvolto. Da allora, lavorando, continuavo a cantare “Di
quella pira”. Era proprio destino che diventassi un cantante
lirico>>.
Il 31 agosto scorso, il maestro Bergonzi è
stato premiato all’Arena di Verona con L’Oscar della lirica. Ora,a
Venezia, oltre al premio “Una vita nella musica”, ha ricevuto un
riconoscimento anche dal Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, una medaglia d’oro, con una dedica che lo stesso
Napolitano ha voluto dettare: “Al maestro Carlo Bergonzi, interprete
sommo del repertorio verdiano, e custode illustre della tradizione
belcantistica italiana”.
Bergonzi è veramente un personaggio unico, il
cui valore artistico, nel campo della lirica, non ha paragoni.
Secondo i critici di tutto il mondo, è stato il tenore verdiano per
eccellenza. Forse il più fedele e autentico interprete delle opere
del “cigno di Bussetto” di tutti i tempi. Certe pagine verdiane come
le ha interpretate lui, non le interpreterà più nessun altro.
L’atmosfera di commozione, di magia che riusciva a creare con la sua
voce incantando le platee più esigenti ed esperte, resterà
irripetibile.
L’origine di questo artista è contadina. Non ha avuto la possibilità
di frequentare scuole importanti. Anzi, come egli stesso racconta,
nel canto non ha proprio avuto maestri di nessun genere. Si è fatto
da solo. Ma, forse, essendo nato nella terra di Verdi, avendo
respirato l’aria che respirava Verdi, potrebbe essersi verificato un
magico e misterioso fenomeno di osmosi: il grande compositore
potrebbe avere trasmesso al ragazzo Bergonzi quelle intuizioni, quei
segreti, quegli accorgimenti tecnici e stilistici che gli hanno
permesso poi di indicare vie rivoluzionarie nell’interpretazione
delle opere del maestro.
Bergonzi non è solo il tenore dal timbro caldo
e squillante, dalle mezze voci mirabolanti, dai falsetti insinuanti
e torniti, dalla garbatezze danzanti e suadenti, è il maestro
geniale, che ha rivoluzionato il modo di interpretare l’opera
verdiana. Nessuno meglio di lui ha posseduto l’accento verdiano, la
“verità verdiana” che risuona nel canto. Ai ritmi incalzanti, agli
acuti trionfanti, alle melodie popolari e spontanee del compositore
bussetano, Bergonzi ha dato un’anima, una eleganza, una regalità che
restano tributo ineguagliato nella storia.
Nato, cresciuto e vissuto sempre a Busseto, da
un po’ di tempo Bergonzi si trova nel suo appartamento milanese.
<<Ho qualche difficoltà a camminare>>, dice. <<Fino a tre anni fa
ero un terremoto. Pronto ad affrontare lunghi viaggi senza pensarci.
Dopo aver smesso di cantare, mi ero dedicato all’insegnamento. Avevo
la mia Accademia di Belcanto a Busseto, dove venivano allievi da
tutto il mondo. Ma tenevo corsi anche all’estero, in Russia, in
Giappone, e perfino in Cina. Un giorno sono caduto e mi sono rotto
tre costole, poi ho avuto un embolia polmonare, poi l’ernia al
disco: ho capito che dovevo smettere. Ho chiuso tutto, anche la mia
Accademia di Busseto. Tutto finito, quindi, ma ogni giorno ringrazio
Dio per tutto quello che mi ha dato e per avermi conservato la mente
lucida, fresca, con una memoria da elefante, che mi fa sentire, a 86
anni, ancora giovane come un tempo>>.
E approfittando della sua prodigiosa memoria, abbiamo chiesto al
maestro Bergonzi di ricordare, in questa lunga ed esclusiva
intervista, i momenti più importanti della sua vita e della sua
carriera.
<< Mio padre faceva il casaro e io cominciai a lavorare con lui
quando avevo sei anni>>, racconta il maestro. <<Anche se eravamo
povera gente, senza studi e senza cultura, Verdi e la sua musica
riempivano il nostro cuore. Nel caseificio, dove iniziavamo a
lavorare alle quattro del mattino, le arie verdiane erano
l’espressione della nostra gioia di vivere e confortavano la
monotonia della dura fatica>>.
 E’
vero che la musica verdiana ce l’hai sempre avuta nel sangue, quasi
ti fosse stata trasmessa geneticamente?
E’
vero che la musica verdiana ce l’hai sempre avuta nel sangue, quasi
ti fosse stata trasmessa geneticamente?
<<Non saprei rispondere. Nella mia famiglia non
ci sono mai stati musicisti o cantanti professionisti. E’ un fatto
però che ho sempre amato svisceratamente Verdi, fin da bambino.
Quando sentivo mio padre e gli altri contadini cantare le romanze
dalle opere di Verdi, restavo incantato ad ascoltare. Le imparavo
subito e continuavo a cantarle anch’io con passione. Come ti ho già
detto, a nove anni mio padre mi portò a teatro e vedere “Il
Trovatore” e rimasi sconvolto. Giurai a me stesso che sarei
diventato un cantante lirico. E da allora non ho avuto altri scopi
nella mia vita>>.
E’ stato difficile realizzare questo sogno?
<<All’inizio le difficoltà sono state molte.
Non di tipo musicale. Sembrava però che intorno a me ci fosse una
specie di congiura per impedirmi la carriera musicale. I primi
ostacoli arrivavano dal fatto che io, dopo la quinta elementare,
avevo smesso di andare a scuola e avevo cominciato a fare il casaro
insieme a mio padre. Quando poi, a 16 anni, decisi di studiare
canto, dovetti riprendere i libri in mano e mi resi conto che avevo
dimenticato tutto. Fu molto duro ricominciare da capo>>.
Chi ti convinse a fare quella scelta?
<<Cantavo facendo il formaggio, e tutti
dicevano che avevo una bella voce. “Perchè non studi canto?”
azzardava qualcuno. All’inizio la proposta mi sembrava assurda. Ma a
forza di sentirmela ripetere cominciai a prenderla in
considerazione. Ci fantasticavo sopra. “Forse potrei farcela”, mi
dicevo. Un giorno andai a trovare un ex baritono di Busseto per
chiedere un giudizio tecnico sulla mia voce. “Sei ancora troppo
giovane”, disse. “Ma la voce c’è. Potresti diventare veramente un
cantante”. Quelle parole scatenarono la mia immaginazione e il mio
entusiasmo. Cominciai a fare progetti. E cominciai anche a chiedere
a mio padre di poter riprendere gli studi>>.
E tuo padre?
<<A lui le difficoltà parevano insormontabili.
Non avevamo soldi. Il mio lavoro in cascina era indispensabile.
Comunque, non mi ostacolò. “Prova”, disse. Continuai ad andare a
lavorare regolarmente, ma ripresi a studiare. Tutto il tempo libero
lo passavo sui libri per superare l’esame di ammissione al
Conservatorio. E ce la feci. Fui ammesso al Conservatorio “Arrigo
Boito” di Parma. Al mattino mi alzavo prima delle quattro e andavo
in cascina a fare il formaggio, poi, prendevo il treno e andavo al
Conservatorio. Studiai canto, pianoforte e frequentai le scuole
medie per avere un po’ di cultura. Furono anni preziosi per la mia
formazione anche se gli insegnanti non avevano capito niente della
mia voce>>.
In che senso?
<<Dicevano che ero un baritono e mi fecero
studiare per quel registro. Grazie all’intuizione dei miei
insegnanti, per dieci anni studiai e cantai convinto di essere un
baritono. Ma ancor prima di finire la scuola, quando avevo poco più
di 18 anni, sulla mia strada si presentarono altre difficoltà che
insidiarono non solo la mia voce ma anche la mia vita stessa>>.
Che tipo di difficoltà?
<<La guerra. Nel 1943 fui chiamato al servizio
militare. Mi mandarono a Mantova, nella contraerea. E quando arrivò
l’armistizio, l’8 settembre sempre di quell’anno, i miei compagni
scapparono e tornarono quasi tutti a casa. Io invece ero a letto con
quaranta di febbre, fui preso dai tedeschi, portato in barella nel
campo sportivo e da lì spedito in Germania, destinato ai campi di
concentramento. Il viaggio verso la Germania, durato tre giorni, in
un treno che serviva per il trasporto del bestiame, lo feci con la
febbre che mi divorava, senza acqua e senza cibo. Fu un miracolo se
sopravvissi. Ma qualcuno, dal cielo, certamente vegliava su di me>>
 Quanto
tempo sei rimasto prigioniero dei tedeschi in Germania?
Quanto
tempo sei rimasto prigioniero dei tedeschi in Germania?
<<Ventisei mesi. Sono finito sul Baltico, ai
confini con la Polonia. Alloggiavamo in un campo di baracche di
legno e lavoravamo alla costruzione di una linea ferroviaria.
D’inverno faceva molto freddo. Anche trenta gradi sotto zero. Si
mangiava da cani, patate e brodo d’erba. Durante quei mesi mi sono
ammalato molte volte, ma non potevo restare a letto. Andavo a
lavorare febbricitante. A volte la testa mi girava e non vedevo
neppure la strada, tanto ero frastornato. Sono tornato a casa che
pesavo 35 chili. Mia madre, quando mi vide, mi guardava sospettosa.
Non corse ad abbracciarmi e continuava a ripetere: “No, questo non è
mio figlio”>>.
Giuseppe di Stefano e Mario Del Monaco mi
hanno raccontato che, durante la guerra, loro, per il fatto che
avevano una bella voce e sapevano cantare romanze d’opera, erano
stati trattati bene, avevano evitato sacrifici e fame. Tu non hai
avuto questa fortuna?
<<No. In campo di concentramento non avevo
quasi neppure fiato per reggermi in piedi, immagina se ne avevo per
cantare. Alla fine della guerra, invece, quando arrivarono i russi a
liberarci dal Lager, la voce probabilmente mi salvò la vita. Mi
ammalati di tifo e non c’erano medicine per curarlo. Ero divorato
dalla febbre e credevo proprio di morire. Un giorno i prigionieri
organizzarono una festa per i soldati russi e io, nonostante la
febbre, volli cantare alcune romanze. In prima fila c’era un
capitano sovietico, amante di lirica, che si entusiasmò della mia
voce e mi prese subito sotto la sua protezione. Il giorno dopo mi
invitò a mangiare alla mensa ufficiali. Saputo che ero ammalato, mi
fece visitare da un medico di sua fiducia e mi fece curare con delle
medicine vere. Credo che quel capitano mi abbia veramente salvato l
vita. E purtroppo non ho mai potuto ringraziarlo.
<<Mentre ero ancora ammalato, arrivò la tradotta che doveva
riportarci in Italia. I miei compagni si prepararono per il viaggio,
ma io non potevo partire in quanto ero ammalato e ricoverato in
isolamento. Ma i miei compagni non vollero lasciarmi là. Vennero a
prendermi di notte e mi nascosero sul treno. Così partii senza poter
salutare quel capitano che mi aveva fatto curare. Se lo avessi
fatto, mi avrebbe certamente impedito di viaggiare in quelle
condizioni e sarei dovuto rimanere>>.
Al ritorno hai naturalmente ripreso a
studiare canto.
<<Immediatamente e con più grinta di prima.
Dopo tutto quello che avevo sofferto, volevo spaccare il mondo.
Conclusi i miei studi al Conservatorio di Parma e poi mi trasferii a
Milano per tentare la fortuna. Milano era anche allora la capitale
di tutte le iniziative, comprese quelle musicali.
<<Trovai alloggio in periferia. Nel ‘47, qualcuno mi disse che c’era
la possibilità di debuttare nel “Barbiere di Siviglia” di Rossini.
Non era una grande occasione. Si trattava di cantare in un teatrino
parrocchiale, a Varedo, piccolo centro dell’hinterland milanese.
Comunque era sempre un debutto e mi pagavano anche. Accettai.
<<Facemmo poche prove. Il direttore era un certo Lomonaco.
L’orchestra era costituita da un contrabbasso, due violini, un
flauto, il pianoforte e la grancassa. La quinte del palcoscenico
erano di carta. Quando uscii con la chitarra per cantare “Largo al
factotum”, il manico della chitarra si impigliò in una quinta io,
preoccupato e confuso per il debutto, non me ne accorsi e tirai giù
tutto. La gente rideva, fischiava, lo spettacolo venne sospeso e,
dopo aver ricostruito lo scenario, si riprese tutto da capo. Per
fortuna non accaddero altri incidenti e alla fine ebbi anche
successo>>.
Così debuttasti come baritono.
<<Non solo debuttai, ma per tre anni continuai
a cantare da baritono. In genere sostenevo parti secondarie, di
secondo piano, ma cantavo molto>>.
Tu hai insegnato per molti anni: come ti
spieghi il fatto che nessuno si fosse accorto che, dentro quella tua
voce di baritono, si nascondeva una meravigliosa voce di tenore?
<<Eravamo in tanti cantanti giovani, tanti
baritoni, tanti tenori, nessuno stava lì a sottilizzare troppo.
L’importante era trovare una scrittura. Quando diventai un tenore
famoso, tutti i direttori d’orchestra con i quali cantavo, da
Serafin a Guarnieri, da Gavazzeni a Votto, Capuana, Ghione, tutti
dicevano: “Lo sentivo io che aveva la voce di tenore”. Ma in realtà,
quando facevo il baritono, nessuno mi disse mai niente>>.
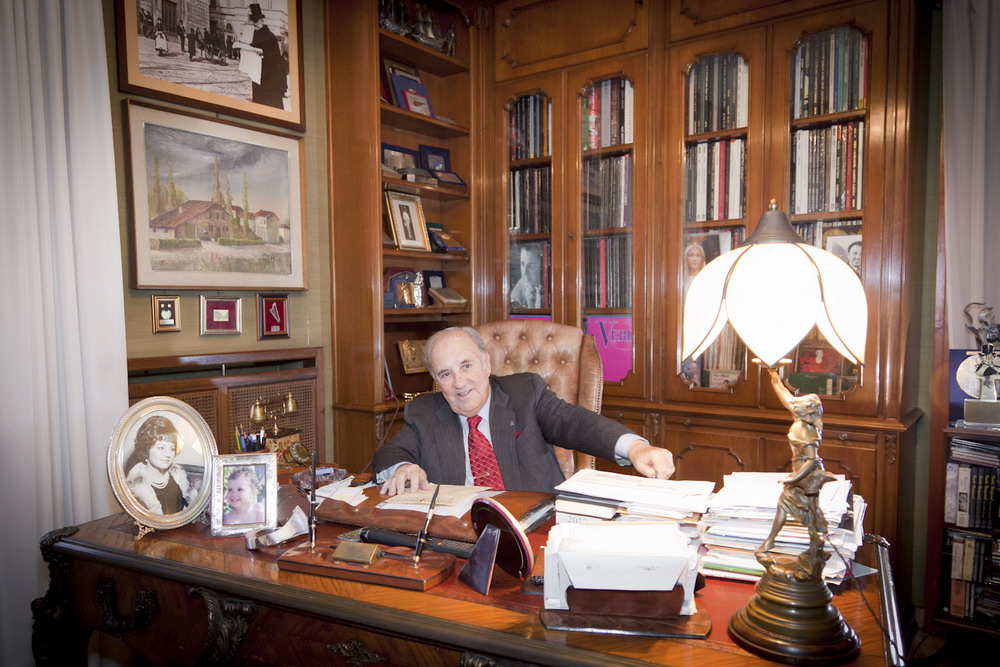 Pensi
che aver cantato per tre anni da baritono abbia nuociuto alla tua
voce di tenore?
Pensi
che aver cantato per tre anni da baritono abbia nuociuto alla tua
voce di tenore?
<<Al contrario, ha fatto molto bene. Ho
rassodato le note gravi, preparando un solido trampolino di lancio
per i futuri acuti. E’ come se, dovendo costruire un palazzo, avessi
posto delle fondamenta massicce in cemento armato. Quando passai al
registro di tenore avevo una struttura basilare di straordinaria
potenza>>.
Chi ti ha convinto a compere quel passaggio?
<<Nessuno. Ho fatto tutto da solo. E in gran
segreto anche. Mi accorsi che la voce faticava nei ruoli baritonali.
Sentivo che non ero a mio agio in quel registro. Invece avevo una
grande facilità nell’affrontare gli acuti. “Vuoi vedere che sono un
tenore”, mi dicevo. E ruminavo dentro di me questo problema. Due
erano le possibili soluzioni e tutte e due pericolose. O facevo
finta di niente e continuavo a cantare da baritono con la certezza
che sarei rimasto sempre un mediocre, un cantante di seconda
categoria; oppure tentavo di passare al registro tenorile con
l’incognita però di fallire e quindi di essere costretto a chiudere
la carriera lirica e tornare a fare il formaggio. Decisi di tentare.
<<Eravamo nell’estate del 1950. Portai a termine gli impegni già
presi e poi cominciai a lavorare per “registrare” la mia voce. Non
avevo confidato i miei problemi a nessuno, neppure a mia moglie
Adele. Approfittando che aspettava un bambino, la consigliai di
andare a vivere da sua madre, così a Milano potevo dedicarmi alla
mia “trasformazione”. Lavoravo da solo, senza maestri, con un metodo
che mi ero inventato io. Avevo come supporto solo il diapason, cioè
quel piccolo strumento acustico che produce una sola nota, il “la”,
e serve per accordare gli strumenti. Me ne servivo per “accordare”
le mie corde vocali. In tre mesi, guadagnando un quarto di tono al
giorno, diventai tenore. Allora preparai due opere, “Aida” e “Andrea
Chenier” e andai a farmi sentire da un impresario che mi propose
delle recite di “Andrea Chenier” a Bari. “Mi sta bene”, risposi. Il
12 gennaio 1951, debuttati come tenore al Petruzzelli di Bari
ottenendo un buon successo. Quello stesso giorno nacque mio figlio
Maurizio. Cominciò così la mia carriera come tenore>>.
Hai superato quel problema da solo: quindi
come tenore sei un autodidatta.
<<Proprio così. Non ho avuto maestri e neppure
insegnanti. Ho fatto tutto da solo. Ho studiato la mia voce, ho
inventato il metodo per alleggerirla, per rafforzare gli acuti. Di
fronte ad ogni difficoltà riflettevo e cercavo di trovare una
soluzione tecnica che mi andasse bene.
<<A questo lavoro però, sia pure inconsciamente, mi ero preparato da
tempo. Sembrava che dentro di me sentissi che avrei dovuto
incontrare dei problemi del genere. Infatti, durante i tre anni di
attività come baritono ebbi la fortuna di cantare accanto ai più
grandi tenori del tempo, Gigli, Schipa, Pertile, Tagliavini, Masini,
e continuavo a chiedere loro consigli e informazioni. Osservavo come
vivevano, cosa mangiavano, quali abitudini di vita tenevano. Prima
della recita, mi fermavo di fronte ai loro camerini per sentire
quali vocalizzi facevano per scaldare la voce. Nei momenti di pausa,
in albergo, ero sempre accanto a loro, li interrogavo. Insomma ero
molto curioso di tutto. Ebbi modo così di ottenere consigli
preziosi. Gigli mi parlava del diaframma, dell’importanza di saper
usare il diaframma. Schipa mi decantava l’opportunità di rispettare
il repertorio adatto alla propria voce. Ognuno mi dava un consiglio
e io mettevo dentro la mia memoria. Al momento giusto tutte quelle
informazioni diventarono una miniera d’oro per me. Posso dire di
essere stato un autodidatta nel preparare la mia carriera di tenore,
confortato però e aiutato dai consigli di quei miei grandi e
illustri colleghi>>.
 Hai
dovuto fare una lunga gavetta prima di raggiungere la definitiva
affermazione?
Hai
dovuto fare una lunga gavetta prima di raggiungere la definitiva
affermazione?
<<Un colpo di fortuna mi ha portato subito alla
ribalta. A Bari, dove cantai “Andrea Chenier”, c’era il direttore
generale della Rai, che fu molto colpito dalla mia voce. Venne a
trovarmi e mi fece un discorso di questo genere: “Quest’anno, 1951,
ricorrono i cinquant’anni dalla morte di Verdi. Alla radio faremo
una grande stagione lirica eseguendo tutte le opere del maestro di
Busseto. Abbiamo bisogno di alcuni tenori giovani che siano pronti
per sostituire i grandi interpreti nel caso vengano colpiti da
qualche indisposizione. Io ti scritturo per sei mesi, a 50 mila lire
al mese. In più ti faccio cantare in due opere: “Giovanna d’Arco” e
“I Due Foscari”, con un cachet di 50 mila lire a opera”. Mentre lui
parlava, mentalmente feci dei rapidi conti: 50 mila lire al mese per
sei mesi facevano 300 mila lire; più altre cento mila per le due
opere si arrivava a un totale di 400 mila lire. Una cifra per me
iperbolica, inimmaginabile. Ero pieno di debiti. Vedevo risolti d’un
tratto tutti i miei problemi economici. “Benissimo, accetto
volentieri”, risposi con entusiasmo.
<<E quello fu il più bel contratto della mia vita. Anche perchè poi,
in pratica, quasi tutti i tenori titolari delle varie opere si
ammalarono e io li sostituii ottenendo successo e soprattutto
facendomi conoscere nel mondo della lirica. Infatti, allora non
c’era la televisione. Gli appassionati di lirica, gli addetti ai
lavori, i direttori d’orchestra ascoltavano le opere che venivano
trasmesse alla radio e così, in quei sei mesi mi feci conoscere da
tutti, non solo in Italia ma anche all’estero, e la mia carriera
partì come un razzo>>.
Verdi, quindi, ti portò fortuna e diventasti
fin da allora il tenore verdiano per eccellenza.
<<Per la verità io cantavo di tutto. Avevo una
grande facilità a imparare le opere in fretta. Per questo il mio
repertorio divenne, in poco tempo, vasto: 74 opere. Avevo però una
predisposizione per le opere di Verdi. Infatti, le ho cantate tutte,
tranne due: “Otello” e “Falstaff”, per le quali non mi sentivo
portato>>.
Quali opere verdiane hai cantato di più?
<<“Aida”, “Trovatore”, “Ballo in maschera” e
“Forza del destino”. Ma ho affrontato molto, e con grande
soddisfazione, anche “Luisa Miller”.
I critici riconoscono che, nella storia del
melodramma, il tuo modo di interpretare le opere verdiane ha segnato
una svolta. Tu hai indicato percorsi nuovi, sensibilità diverse,
attenzioni speciali. Chi ti ha guidato in questo ricerca?
<<Nessuno. Come ho detto, io sono un
autodidatta. Quando dovevo studiare una nuova opera di Verdi,
prendevo lo spartito e lo esaminavo attentamente, frase per frase.
Mi sono accorto che Verdi ha indicato tutto quello che l’interprete
deve fare. Frasi brevi, ma precise: “mezzavoce”, “due p”, “tre p”,
“col canto”, “rinforzato”, “smorzando”, eccetera. Io riflettevo
molto su quelle indicazioni e poi cercavo di eseguire la frase come
era indicato. Tutto qui>>.
Quali sono i teatri dove hai cantato di più?
<<Metropolitan, Scala, Covent Garden,
Staatsoper di Vienna, Arena di Verona, ma in pratica in tutti i
teatri importanti del mondo>>.
 Ricordo
che è stato memorabile il tuo concerto di addio alla Scala nel 1993.
Hai iniziato con una canzone popolare: “Non ti scordar di me”.
Ricordo
che è stato memorabile il tuo concerto di addio alla Scala nel 1993.
Hai iniziato con una canzone popolare: “Non ti scordar di me”.
<<Quel teatro ce l’ho nel cuore. Anche se ho
cantato molto di più al Metropolitan, la Scala è il teatro di casa
mia. Iniziando quel concerto ho voluto subito dire al pubblico che
non volevo essere dimenticato. E il pubblico si è commosso, come del
resto lo ero anch’io.
<<Alla Scala avevo debuttato il 25 marzo 1953, quaranta anni prima.
Non era stato un debutto fantastico. Anzi. Interpretavo un’opera
nuova, il “Mas’Aniello”, di Jacopo Napoli, e il pubblico non la
gradì. Continuava a rumoreggiare e a fischiare. Non era facile
cantare in quella situazione perciò non ho un buon ricordo di quel
debutto. Poi però sono arrivate le opere del mio repertorio “Aida”,
“Trovatore”, “Forza del destino”, “Un ballo in maschera”, che mi
hanno dato grandissime soddisfazioni.
<<Fin dall’inizio io ero cosciente di non essere un Adone. Bastava
che mi guardassi allo specchio per capire. Non avevo il fisico di
Corelli per intenderci. Quindi, se volevo incantare il pubblico
dovevo farlo solo con la voce, con la magia del canto. E questa è
stata la mia arma. Anche alla Scala spesso è accaduto che, dopo
qualche aria, il pubblico balzava in piedi, in delirio. Sono momenti
che non si possono dimenticare. Per questo, in quel concerto
d’addio, ho voluto iniziare con la canzone “Non ti scordar di me”.
Che poi ho ripetuto anche alla fine. La stessa canzone l’ho cantata
anche nel concerto d’addio al Metropolitan e il giorno dopo il
“Time” intitolava l’articolo di cronaca di quel concerto: “No, non
ti dimenticheremo mai”>>.
Quanti concerti d’addio hai fatto prima di
chiudere definitivamente la tua carriera?
<<Non lo so. Diversi. Ho fatto il giro dei vari
teatri dove avevo cantato tante volte. In alcuni teatri sono poi
tornato a fare un secondo concerto d’addio, e anche un terzo. A
Zurigo ho fatto quattro concerti d’addio. All’ultimo, ho concesso
sette bis. Alla fine è venuto fuori il sovrintendente, mi si è
inginocchiato di fronte, sul palcoscenico, con un mazzo di fiori in
mano e ha detto: “Questi sono per il suo cinquantesimo anniversario
di carriera, ma anche per supplicarla di tornare l’anno prossimo”.
<<Per cinque anni sono passato da un teatro all’altro tenendo
concerti di addio. Ogni volta giuravo a me stesso che era l’ultimo,
ma poi, dopo qualche mese, ecco un nuovo appuntamento.
I direttori dei teatri mi chiamavano, io mi sentivo bene, la voce
rispondeva, la voglia di cantare era grande, e allora andavo. Certo,
non potevo ipotecare l’avvenire. Non firmavo contratti. Dicevo: “Se
mi sentirò bene, verrò”. E sono andato avanti.
<<Un estraneo non può capire che cosa significhi per un artista
smettere di cantare. Ci si sente improvvisamente finiti, morti. E’
come se ti tagliassero le mani, le gambe, la lingua. Per fortuna, io
avevo la scuola che mi permetteva di continuare a interessarmi di
lirica, di voci, di teatro, altrimenti guai. Ma ad un certo momento
ho dovuto lasciare anche la scuola. La vita ha un suo giro e bisogna
rassegnarsi>>.
Qual è il segreto di tanta longevità della
tua voce?
<<La tecnica. Come ti ho detto, nel periodo in
cui cantavo da baritono continuavo a chiedere ai grandi del tempo
come allenavano la loro voce. La loro esperienza è stata una regola
di vita per me>>.
Quando insegnavi nella tua Accademia, avevi certamente dei “segreti”
da trasmettere ai tuoi allievi.
<< Nell’arte del canto, non esistono “segreti”, ma esistono invece
delle regole semplici e fondamentali. Primo: imparare a respirare e
a usare il diaframma. Questo è basilare. E lo si apprende
soprattutto osservando e ascoltando chi è veramente esperto
nell’arte di questo esercizio. Secondo: rispettare il proprio ruolo
vocale. Un campione di atletica leggera specialista nei cento metri
non si metterà mai a gareggiare anche sul miglio: sarebbe la sua
fine. Così un cantante lirico. Una volta c’erano le categorie e
venivano rispettate con scrupolo. Solo per il registro tenorile
avevamo: il tenore di grazia; il tenore leggero; il tenore lirico
leggero; il tenore lirico; Il tenore lirico spinto; il tenore
drammatico. E’ estremamente importante non forzare la voce e quindi
non uscire mai dal proprio ruolo vocale. Purtroppo, oggi, questa
regola viene ignorata. Anche perchè molti direttori artistici e
direttori d’orchestra non se ne intendono di voci. La conseguenza è
drastica. Ogni tanto sentiamo parlare di un giovane con una bella
voce. Dopo cinque sei anni non lo si sente più nominare. Dov’è
finito? Lo hanno fatto cantare opere non adatte ai suoi mezzi e si è
rovinato.
<<Una terza regola importante è quella del regime di vita. Il
cantante deve condurre un’esistenza serena, regolare, morigerata,
rispettosa dei cicli biologici, insomma piena di sacrifici.
<<Un giorno ero a pranzo con la figlia di Gigli. In un tavolo
accanto c’era suo padre con la moglie. Alla fine del pranzo vedevo
Gigli che scriveva. “Tuo padre prende appunti”, disse a Rina. E lei:
“No, ha scritto sul foglietto un ordine per il cameriere: il giorno
della recita non parla mai, neppure una parola”.
<<Ero a Buenos Aires. Verso le dieci e trenta uscii dall’albergo per
fare una passeggiata e incontrai la grande Ebe Stignani con il
marito. “Signora, anche lei va a passeggiare?”. “No, vado al
ristorante”, rispose. “A quest’ora?”. E lei mi raccontò che il
giorno della recita pranzava sempre nove ore prima di andare in
palcoscenico e faceva un pranzo molto leggero. Glielo avevano
insegnato i vecchi cantanti, trent’anni prima.
<<Era un periodo in cui io accusavo piccoli disturbi alla voce: un
po’ di catarro, pesantezza, opacità. Andavo a pranzo alle due e
mangiavo forte, perchè pensavo che poi, alla sera, alla recita,
avrei avuto bisogno di tante energie. Volli provare il consiglio di
Ebe Stignani. Cominciai ad andare a pranzo alle undici e mangiare
leggero. La voce tornò fresca, aerea, squillante. Scoprii che si
canta meglio a digiuno. Da allora il giorno della recita ho sempre
pranzato alle undici del mattino.
<<Un giorno ero a Salisburgo per interpretare il “Requiem” di Verdi
al celebre Festival. Dirigeva Herbert Von Karajan. Poichè avevamo
avuto poche prove, il maestro ci chiese di fare una ripassatina
anche il giorno della recita, alle undici del mattino. “Maestro”,
gli dissi “io non posso venire”. E, con grande sincerità, gli
raccontai che avevo preso l’abitudine di mangiare, il giorno della
recita, una bistecca proprio a quell’ora. Se avessi cambiato orario
potevo averne un danno. “Per carità”, disse Karajan “vai a mangiare
la bistecca, ti dispenso dalla prova”. Alla sera feci una recita
stupenda. E mentre uscivamo a ringraziare il pubblico che non finiva
di applaudire, Karajan, battendomi una mano sulla spalla, mi disse:
“Continua sempre a mangiare la tua bistecca alle undici”>>.
 Sei
stato molto amico di Karajan ed hai cantato cose eccelse diretto da
lui.
Sei
stato molto amico di Karajan ed hai cantato cose eccelse diretto da
lui.
<<Il maestro Karajan aveva molta stima di me e
per otto anni abbiamo lavorato bene insieme poi i nostri rapporti si
sono bruscamente guastati. Eravamo a Berlino, ultima recita di
“Trovatore”. Venne in camerino un assistente di Karajan e mi disse
che il maestro mi voleva alla Scala nei “Pagliacci”. Non avevo mai
interpretato quell’opera e non me la sentivo di debuttarla alla
Scala, perciò rifiutai. “L’ho ha detto il maestro”, ripetè,
meravigliato, l’assistente. “Un momento”, risposi “adesso parlerò
anch’io con Karajan”. Poco dopo il grande direttore era nel mio
camerino. “Carlo”, disse “perchè non vuoi fare i Pagliacci?”.
“Maestro, non vorrei debuttare in quest’opera alla Scala”, obiettai.
“Non ti devi preoccupare”, disse lui. “Ti guido io”. “Ma sono io che
canto e non voglio rovinarmi”. Si arrabbiò. “Se tu non accetti di
fare i Pagliacci”, disse con tono offeso “non canterai mai più con
il maestro Karajan” e uscì sbattendo la porta. In quel momento
tornai ad essere il “casaro” di Busseto, il contadino che non
accetta soprusi di nessun genere. Balzai alla porta, la aprii, presi
Karajan per il bavero del frac e lo tirai di forza nel camerino.
Chiusi la porta e fissando il maestro negli occhi gli dissi: “Lei è
un grande direttore e mi dispiace non cantare più con lei. Ma io per
lei non mi rovino. E non mi faccio neppure sbattere la porta in
faccia”. Mi girai dall’altra parte. Lui uscì e non lo vidi più.
Avevo un altro contratto con il Festival di Salisburgo, che fu
naturalmente cancellato>>.
Hai, quindi, litigato con Karajan. Eppure ho
sempre sentito dire che eri un’eccezione nel tuo ambiente proprio
perchè non hai mai avuto scontri con nessuno dei tuoi colleghi>>.
<<E’ vero, sono sempre andato d’accordo con
tutti. Anche con tutti i direttori d’orchestra. Ma non significa che
mi lasciassi mettere i piedi sulla testa. Si dice che i tenori tra
di loro si sbranino. Io sono stato amico di tutti i tenori del mio
tempo e uno dei più bei regali ricevuti nel corso della carriera me
lo ha fatto proprio un tenore, Mario Del Monaco.
<<Cantavo a Parigi “Manon Lescaut” di Puccini. Dopo “Guardate, pazzo
son” nel terzo atto, ho sentito partire dal pubblico un “Bravo” che
sembrava l’esultate dell’”Otello”. Vado in camerino per
l’intervallo. Bussano, apro e arriva Mario Del Monaco. “Lei mi ha
dato un’emozione grandissima. Mi ha fatto capire come deve cantare
Des Grieux. A novembre sarò al Metropolitan di New York con due
opere, “Aida” e “Trovatore”. Mi piacerebbe farla conoscere in quel
teatro. Per questo, se lei accetta, le cedo volentieri due recite”.
“Oh, grazie, grazie, è troppo gentile”, risposi. Ero ormai abituato
a sentire tante parole senza che fossero poi seguite da fatti e
dimenticai subito quello che mi aveva detto Del Monaco.
<<A settembre cantavo a Livorno. Arriva nel camerino il signor Bauer,
che era il rappresentante in Europa di Mister Rudolf Bing,
sovrintendente del Metropolitan. Mi fece i complimenti e poi disse:
“Ho una proposta. Mario del Monaco a novembre le cede due recite al
Metropolitan: una di “Aida” e una di “Trovatore”. Lei dovrebbe
trovarsi a New York ai primi di novembre per assistere a un paio di
spettacoli e vedere come sono stati allestiti. Ci pensi e mi dia una
risposta”. Ricordai l’incontro a Parigi con Del Monaco e rimasi
stupefatto. Dissi a mia moglie: “Io ci vado. Per lo meno faccio un
viaggetto in America”.
<<Arrivai a New York, seguii due recite e il 13 novembre mi
presentai in camerino per prepararmi al mio debutto in quel teatro.
In camerino trovai Mario del Monaco che era venuto a darmi qualche
consiglio. Volle truccarmi personalmente e aiutarmi a indossare il
costume di Radames, che era ancora quello usato da Caruso. Feci una
recita magnifica. Dopo il primo intervallo arrivò Mister Bing con un
contratto per tre anni. Sarei certamente arrivato lo stesso al
Metropolitan, ma, sul piano umano, mi ha fatto molto piacere essere
presentato in quel modo da Mario Del Monaco>>.
 Sei
il cantante dei record: 50 anni di carriera, 37 stagioni al
Metropolitan, 19 all’Arena di Verona, 12 alla Scala di Milano, hai
cantato in tutti i più grandi teatri del mondo e interpretato il
“Requiem” di Verdi a 73 anni e lo hai inciso a 74. E, nella vita
privata, quali sono le conquiste di cui vai fiero?
Sei
il cantante dei record: 50 anni di carriera, 37 stagioni al
Metropolitan, 19 all’Arena di Verona, 12 alla Scala di Milano, hai
cantato in tutti i più grandi teatri del mondo e interpretato il
“Requiem” di Verdi a 73 anni e lo hai inciso a 74. E, nella vita
privata, quali sono le conquiste di cui vai fiero?
<<La mia famiglia. Sono sempre stato molto
legato alla famiglia. Nonostante i successi e i trionfi in
palcoscenico, le gioie più belle lo ho avute dalla famiglia. Prima
di tutto da mia moglie, Adele, che è sempre stata accanto a me, mi
ha seguito dappertutto, aiutandomi a sopportare i grandi sacrifici
che questo mestiere impone. Poi i figli, che sono cresciuti bene,
uno è medico e l’altro dirige il nostro l’albergo e ristorante “I
due Foscari”. E adesso anche i nipotini, due, fantastici: Marta e
Carlo. Grande è stata la mia carriera artistica, ma più grande la
mia vita privata>>.
Hai sempre detto di esserti fatto da solo,
di non aver avuto maestri nella tua formazione artistica. Nel
concerto d’addio alla Scala nel ‘93 però hai fatto un pubblico
ringraziamento tua moglie, affermando che senza di lei non saresti
diventato Bergonzi.
<<Ecco, devo ammettere che l’unica maestra che
ho avuto nella carriera artistica è stata proprio mia moglie Adele.
Ha un orecchio formidabile. Non le sfugge niente. Ed è di una
severità inaudita. Non mi ha mai perdonato niente. Facevo delle
recite magnifiche, magari con una sola nota presa male o un po’
sporca, e lei arrivava nel camerino: “Un disastro, hai cantato male,
quella nota non dovevi farla in quel modo”. Mi sentivo morire, la
cacciavo via, ma dentro di me le davo ragione e mi sforzavo per
rimediare. Davanti a me non mi ha mai lodato. Ma, quando non c’ero,
mi difendeva con i denti e diceva a tutti che ero il migliore. Io,
da parte mia, non mi sono mai rassegnato ai suoi tremendi
rimproveri, ma so che, senza di quelli, non sarei arrivato dove sono
arrivato. Siamo veramente una coppia formidabile, nell’arte e nella
vita>>.
Acquista i dischi di Carlo Bergonzi online